Il 16 settembre 2025, nella sede di ESA engineering a Milano, si è tenuto il talk “Data Center del futuro: infrastrutture digitali e strategie urbane”.
In un’epoca in cui la domanda di infrastrutture digitali cresce rapidamente, l’incontro ha proposto una riflessione sul ruolo dei data center nel contesto territoriale, urbano e infrastrutturale italiano. Superando la visione del data center come “scatola tecnica”, il confronto si è concentrato sulle implicazioni sistemiche di queste strutture: dalla pianificazione urbanistica alla gestione delle risorse, dall’integrazione nei masterplan al loro contributo potenziale al funzionamento virtuoso di interi comparti urbani e industriali.
Attraverso una prospettiva multidisciplinare, i relatori hanno discusso strategie di progettazione, localizzazione e coesistenza con il territorio, per comprendere come i data center possano evolvere da semplici contenitori di dati a nodi attivi e sinergici del tessuto infrastrutturale.
L’evento è stato organizzato da ESA engineering, realizzato con il supporto di Schneider Electric in qualità di technical partner e con il patrocinio di IDA – Italian Data Center Association.

A dare il benvenuto è stato Francesco Gori, CEO di ESA engineering, che ha introdotto il tema evidenziandone le sfide e le provocazioni che comporta. Ha quindi passato la parola al moderatore per avviare il dibattito.
Ad aprire la discussione è stato Alessandro Piva, Direttore dell’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, che ha chiarito il taglio del talk:
«Oggi non vogliamo affrontare il tema solo dal punto di vista tecnico della “scatola”. Ci interessa piuttosto capire come questi edifici si inseriscono nel contesto urbano, quali scambi di valore possono generare e quali opportunità offrono per restituire risorse alla collettività. È una prospettiva meno dibattuta, ma per noi la più interessante».
Piva ha introdotto i tre filoni di discussione: scenari e prospettive, integrazione con il territorio, tecnologie e metodologie.

Scenari e prospettive: i data center come nodi infrastrutturali
Il primo intervento è stato di Daniele Lorenzini, Director – Head of Sustainability & Innovation Technology di ESA engineering, che ha fotografato lo scenario attuale:
«I data center non sono una novità in Italia, ma oggi assistiamo a una spinta straordinaria, trainata da intelligenza artificiale, machine learning e servizi cloud. Per evitare una crescita caotica è necessario uno sguardo ampio, sia sul piano urbanistico che tecnico. Il data center non può più essere considerato un semplice edificio: è un nodo infrastrutturale, e come tale va pianificato».
Lorenzini ha poi aggiunto un approfondimento sul fronte normativo:
«Oggi percepiamo una spinta nazionale a unificare il panorama normativo, per pianificare in modo coerente le “regole del gioco” dal punto di vista urbanistico. Allo stesso tempo, resta aperta la questione delle normative tecniche: il data center è un oggetto unico nel suo genere, in cui la scatola conta poco rispetto al contenuto, e merita quindi un approccio specifico».
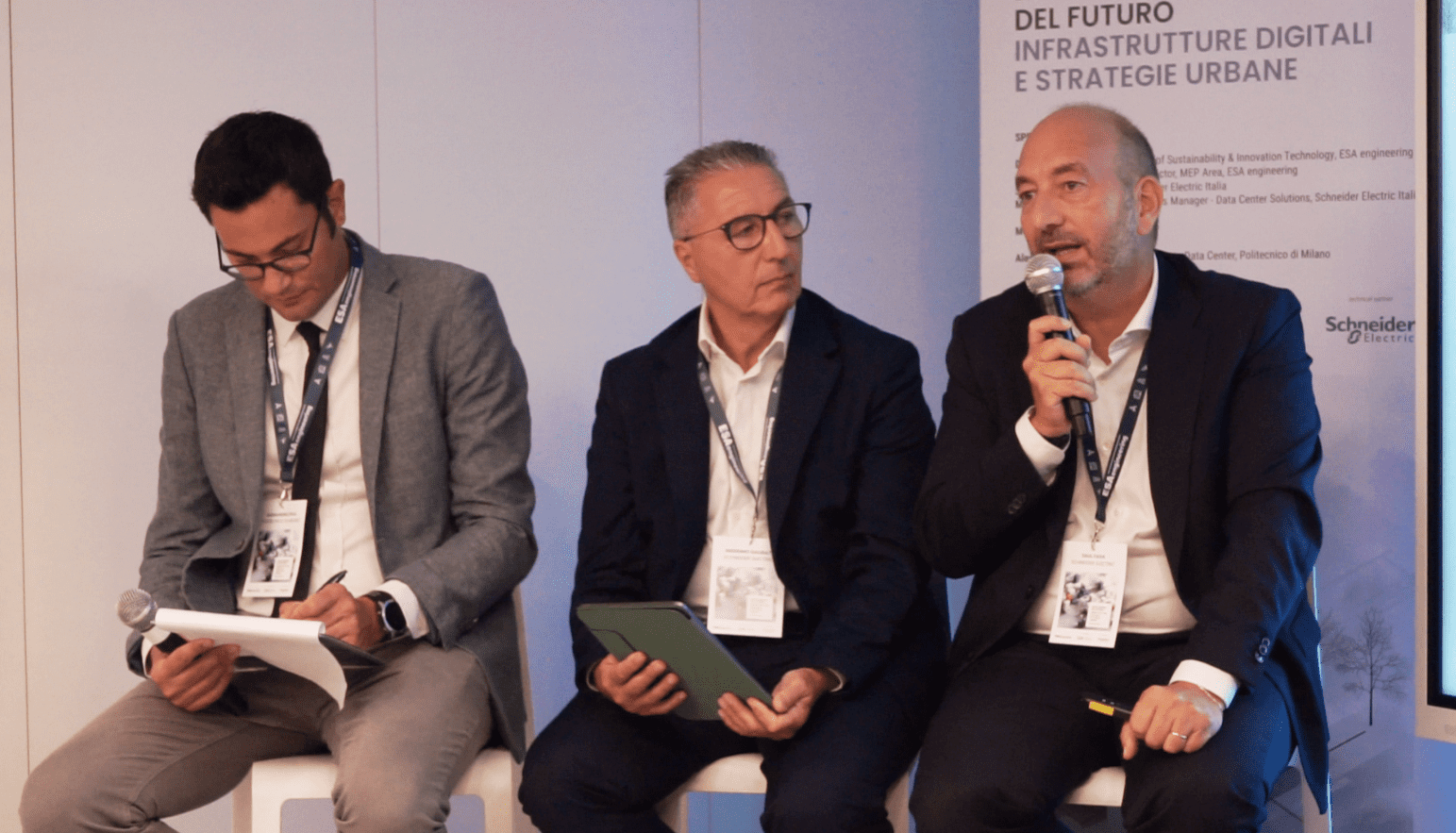
A seguire, Saul Fava, Vice President, Schneider Electric Italia, ha descritto una sfida che si gioca su tre livelli:
«La saturazione dei mercati FLAP-D ha reso Milano un polo di grande attrattività per gli investimenti. Nei prossimi quattro anni la capacità di calcolo richiesta aumenterà di cinque volte. La sfida è triplice: ottimizzare l’infrastruttura che alimenta i processori di calcolo garantendo efficienza e affidabilità; sviluppare soluzioni from chip to chiller per prelevare e smaltire il calore vicino alla sua origine; e infine adottare modelli district, che consentano di restituire questa energia ai territori attraverso reti urbane in grado di valorizzarla».

Integrazione con il territorio: pianificazione e metriche ambientali
Lorenzini è tornato sul tema della collocazione, richiamando l’importanza della pianificazione integrata:
«Recuperare aree dismesse è un’opportunità, ma serve valutare attentamente la compatibilità con le esigenze dei data center. Regione Lombardia ha già avviato una mappatura delle zone non idonee: è un primo passo importante, perché i data center devono diventare parte del disegno urbanistico e non elementi estranei al territorio».
L’intervento ha poi toccato le metriche ambientali definite a livello europeo, che oggi sono già oggetto di monitoraggio ma non ancora di obiettivi vincolanti:
«Esistono parametri che misurano energia, uso dell’acqua, copertura da rinnovabili, riuso termico e impronta di carbonio. Al momento non ci sono target obbligatori, ma questo sarà probabilmente il passo successivo. In generale il PUE resta la metrica di riferimento, perché misura il rapporto tra energia totale in ingresso ed energia effettivamente destinata ai server. Oggi queste metriche si rendicontano: domani dovremo imparare a dare loro priorità in base ai contesti, per evitare danni ai territori».

A questo quadro si è agganciato Massimo Galbiati, Tech & Pre-Sales Manager – Data Center Solutions, Schneider Electric Italia, approfondendo l’aspetto operativo:
«Il PUE resta la metrica più diffusa, ma non è sufficiente. Dobbiamo ampliare lo sguardo a consumo idrico, energie rinnovabili, CO₂ e soprattutto alla capacità di recuperare energia termica. Intercettare e riutilizzare il calore è la vera sfida che il settore deve affrontare: oggi viene rendicontata, domani dovrà diventare un obiettivo vincolante, differenziato per aree geografiche».
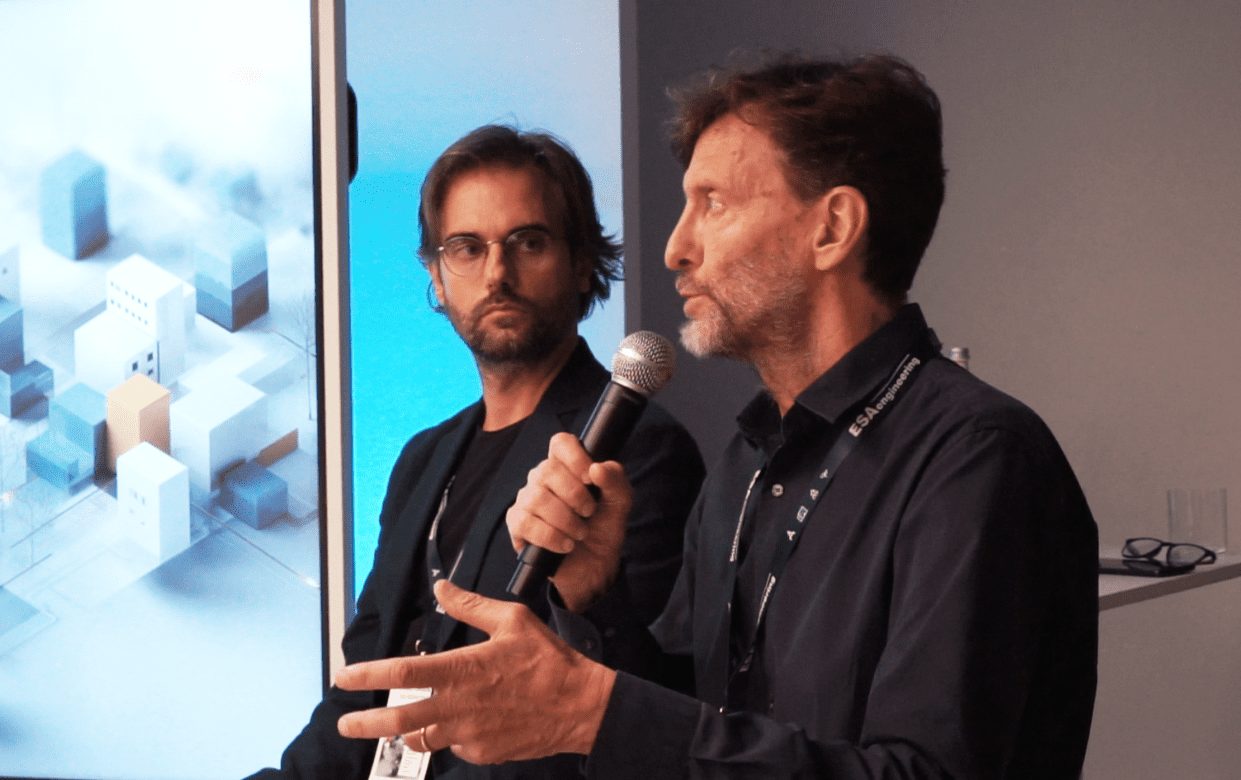
Tecnologie e metodologie
Il dibattito si è poi spostato sugli aspetti tecnologici. Luca Stefanutti, Co-Technical Director – MEP Area, ESA engineering, ha evidenziato il legame tra innovazione tecnica e rigenerazione urbana:
«ESA è attualmente coinvolta in progetti di rigenerazione urbana e questo ci permette di vedere chiaramente la possibilità di trasformare i data center in attori positivi e attivi nei progetti di recupero delle aree. Il recupero del calore, ad esempio, può alimentare edifici e quartieri, trasformando un sottoprodotto in una risorsa. Tecnologie come il raffreddamento a liquido aprono nuove opportunità, mentre metodologie come il free cooling ad aria o il raffreddamento evaporativo risultano problematiche: generano isole di calore o comportano un forte consumo idrico. Se inserito in progetti coordinati, invece, il recupero del calore diventa un vantaggio ambientale ed economico, in grado di attrarre anche gli investitori» Galbiati ha confermato la priorità della gestione termica:
«Il liquid cooling non è una novità, ma oggi rappresenta la leva più efficace per affrontare le sfide presenti e future. La gestione del calore sarà il vero tema strategico del settore».

Una sintesi del dibattito
Dalla discussione è emersa una visione comune: i data center non possono più essere letti come semplici edifici, ma come nodi infrastrutturali che incidono sul territorio e sulle comunità. La pianificazione, le metriche ambientali e le nuove tecnologie di gestione del calore sono i tre ambiti su cui si gioca la loro evoluzione, con l’obiettivo di trasformarli da contenitori di dati a motori di valore condiviso.
Le metriche oggi vengono rendicontate, ma il passo successivo sarà imparare a dar loro una priorità in base ai diversi contesti territoriali, così da garantire un’integrazione virtuosa e non arrecare danni all’ambiente circostante. In prospettiva, l’auspicio è che anche la comunità europea ponga obiettivi chiari e differenziati per fasce territoriali, così da orientare lo sviluppo in modo più equo e sostenibile.
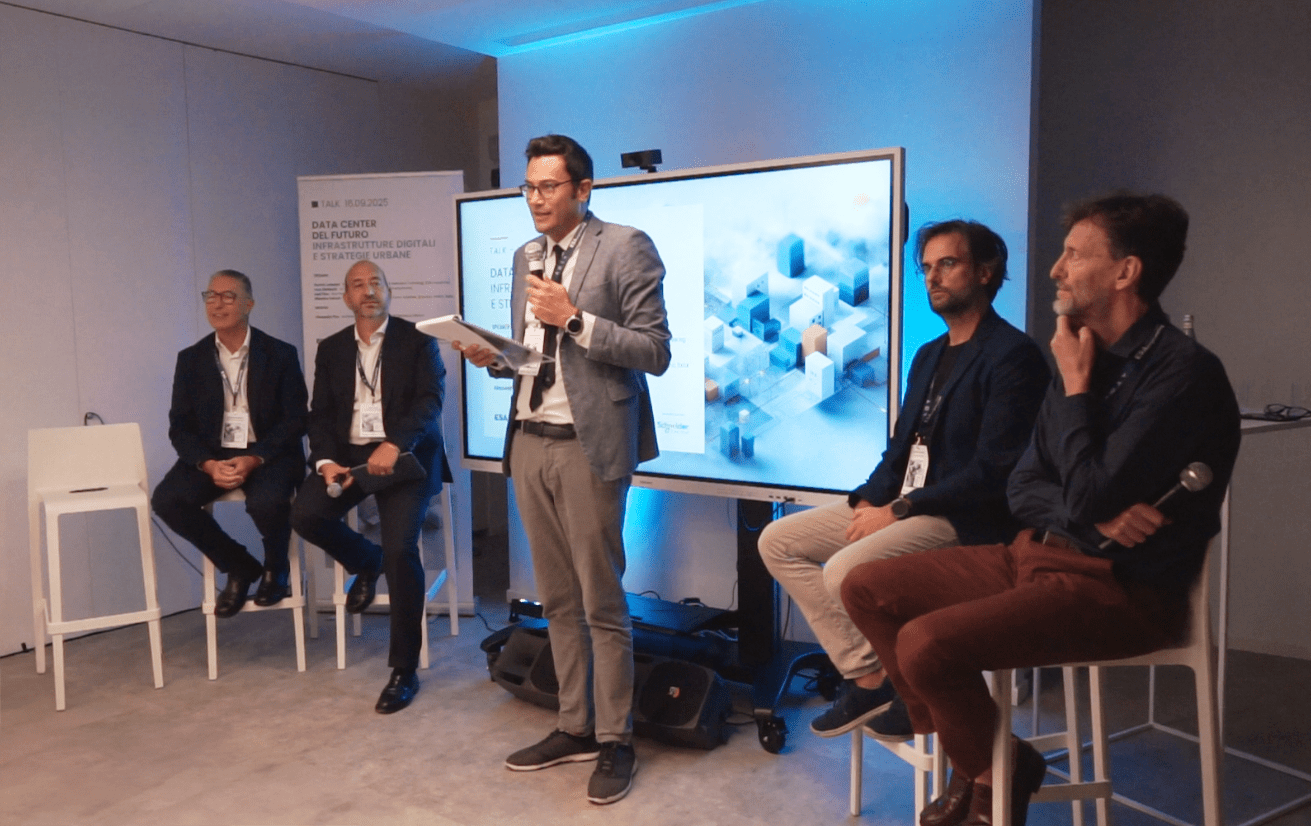
Guardando al futuro
Nella parte conclusiva, i relatori hanno condiviso la loro visione dei data center di domani:
- Saul Fava ha sottolineato che la crescita dell’AI continuerà in modo esponenziale, portando con sé nuove sfide ma anche grandi opportunità di innovazione progettuale.
- Luca Stefanutti e Daniele Lorenzini hanno invitato a ripensare i data center come «attori positivi e attivi, capaci di restituire valore al territorio».
- Massimo Galbiati ha ribadito la necessità di una cornice normativa chiara, che riconosca i data center come nodi infrastrutturali strategici.







